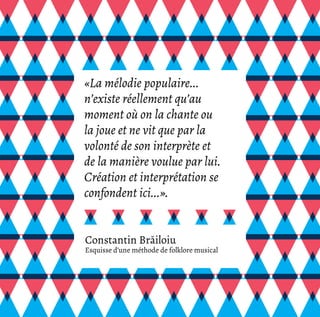
Enfestar LIBRETTO
- 1. «La mélodie populaire... n’existe réellement qu’au moment où on la chante ou la joue et ne vit que par la volonté de son interprète et de la manière voulue par lui. Création et interprétation se confondent ici...». Constantin Brăiloiu Esquisse d’une méthode de folklore musical
- 2. BLU L’AZARD Peyre Anghilante - voce, fisarmonica Flavio Giacchero - voce, clarinetto basso, sax soprano, cornamuse (bechonnet, piva emiliana), registrazioni ambientali Marzia Rey - voce, violino Pierluigi Ubaudi - voce, flicorno baritono Recording live and mixing: Flavio Monti at STUDIO TAN, Tonengo-Mazzè (TO), Italy, May 14-16, 2014. Mastering: SMC RECORDS, Ivrea (TO) Photos: Flavio Giacchero Design: kividesign.it Produced by Chambra d’Òc contacts: Flavio Giacchero +39 349 8513832 blulazard@gmail.com Edicion e produccion Chambra d’Òc Chamin Arnaud Danièl 18 – 12020 Roccabruna (CN) tel. +39 0171 918971 / +39 328 3129801 chambradoc@chambradoc.it www.chambradoc.it n.catSMC-A1407
- 3. Ogni tradizione musicale è sempre stata mutevole, in trasformazione continua, in sintesi: creativa. Questo disco, ENFESTAR, è parte del progetto artistico “Dançar a la chantarèla” / “Balà an chantant” (in occitano il primo, in francoprovenzale il secondo), ideato dalla Chambra d’Òc per la diffusione della cultura e delle lingue minoritarie del Piemonte (occitano, francoprovenzale, francese), realizzato per la Provincia di Torino nell’am- bito della rassegna “Chantar l’uvern” e affidato al gruppo musicale BLU L’AZARD. Un progetto ma anche una specifica tradizione che in italiano è “ballare cantando” o “ballo cantato”. La prassi di danzare sulla voce degli stessi partecipanti al ballo è anti- ca così come ballare sul canto di esecutori esterni. Sebbene si tratti di una pratica attestata in molte culture del mondo, cantare sul ballo era comune nell’Europa me- dievale e rinascimentale ed è una tradizione che anche nelle regioni di lingua occita- na e francoprovenzale è stata documentata, in un continuum storico, all’incirca fino alle due grandi guerre, periodo che segna per gran parte dell’Europa stravolgimento e cambiamento. Ma cantare su un ballo, a ben vedere, perdura senza interruzione temporale, ne sono infatti esempio i girotondi, le filastrocche e i giochi che ancora i bambini eseguono, ignari di essere forse i diretti portatori della tradizione più antica, di estrazione magica. I quattro componenti del gruppo provengono tutti da località di lingua minorita- ria e partecipano attivamente alle specifiche tradizioni culturali di appartenenza (Bahio della Val Varaita; danza delle spade e priorato di Giaglione; canti spon- tanei, danze e musiche nelle Valli di Lanzo), oltre che svolgere attività di musi- cisti e cantanti in ambiti svariati, collaborando con molte realtà e attraversando numerosi generi musicali.
- 4. 1. Bella t’è bella(fp) tradizionale, melodia e alcune strofe di Pierluigi Ubaudi. Da una filastrocca di Groscavallo. Bella t’è bella, balà ‘d balle bin Me fa a nhin voulete bin, matassi N’ aouta pi bella qui bal miai quë te Vala trouvà isì ‘n tou gran jamarè L’aiva dë Stura se fus tout ‘d vin boun É peres dli quiapé é fuset miquë ‘d pan L’aiva dë Stura se fus tout ‘d vin boun Tinme la man quë traversen lou rianc. Bella sei bella Bella sei bella, a ballare balli bene Come si può non volerti bene, graziosa Un’altra più bella che balli meglio di te / Vai a trovarla qui in questa confusione. L’acqua dello Stura se fosse tutta del buon vino E le pietre delle pietraie fossero micche (tipica forma di pane) di pane L’acqua dello Stura se fosse tutta del buon vino / Tienimi la mano che attraversiamo il ruscello. 2.Cese bequin(òc) tradizionale. Uno scottish su un’ antica filastrocca iterativa, dalla caratteristica struttura improv- visativa a domanda e risposta, che rappresenta un mondo magico, assurdo e simbolico: il mondo dell’infanzia. Il testo è stato riportato da Jean- François Bladé e pubblicato tra il 1881 e il 1882 in: Poésies populaires de la Gascogne. Una versione anche in: Gasconha Plus, En dançar, 2007 Cese bequin, anem, anem. Cese bequin ont anirèm? Cese bequin, amassa aglans. Cese bequin, n’i a pas d’engoan. Cese bequin, qui los a minjats? Cese bequin, lo pòrc de lo conte. Cese bequin, ont es lo conte? Cese bequin, dambe madama. Cese bequin, ont es madama? Cese bequin, a la cabana. Cese bequin, dambe madama. Cese bequin, que hè madama? Cese bequin, que coud sabatas. Cese bequin, de qu’a las sabatas? Cese bequin, de pèd de craba. Cese bequin, de qu’a los debàs? Cese bequin, de pèd d’arratz. Cese bequin, de qu’a los soulièrs. Cese bequin, de pèt de betèt. Cese bequin, de qu’a la camisa? Cese bequin, de pèd de hagina. ENFESTAR
- 5. Cese bequin, de qu’a lo cotilhon? Cese bequin, de pèd de moton. Cese bequin, de qu’a la peila? Cese bequin, de pèd d’aoeilha. Cese bequin, de qu’a lo dauantau? Cese bequin, de pèt de chibau Cese bequin, de qu’a la coha? Cese bequin, de pèd d’aoeilha. Cese bequin, de qu’a lou mocadèr? Cese bequin, de pèd d’arré. Cese bequin, de pèd d’arré. Cecio Cecio andiamo, andiamo; … dove andiamo? … a raccogliere ghiande; … non c’è ne sono quest’anno / … Chi le ha mangiate? … il maiale del conte; ... dov’è il conte? … dalla signora / … Dov’è la signora? … nel capanno; … dalla signora; … che fa la signo- ra? / … Cuce zoccoli; … come sono gli zoccoli? … di pelle di capra; … che cosa ha li sotto? / … Delle pelli di topo; … come ha le scarpe? … di pelle di vitello; di cosa è fatta la camicia? / … Di pelliccia di donnola; … di cosa è fatta la sottana? … di pelle di montone; … come sono i vestiti? / … di pelle di pecora; … di cosa è fatto il grembiule? … di pelle di cavallo; ... di cosa è fatta la cuffia? / … Di pelle di cinghiale; … di cosa è fatto il fazzoletto? … di nulla. 3.Gigo tradizionale. Danza tradizionale della Val Varaita (CN), suite. 4.Ël nebbies d’andin(fp) parole Pierluigi Ubaudi, musica Flavio Giacchero. Un canto dall’atmosfera fantastica e surreale. Il desiderio, poetico, di vedere come siano fatte le nu- vole. La presenza universale e contemporanea delle differenze economiche e sociali. Si tratta di una nuova composizione, testimonianza della vitalità di queste lingue, con lo spirito che permea tutto il progetto del gruppo: la creatività. Come danza è un circolo circassiano, ballo dalle origini nordiche ma ormai, per la semplicità delle figure e il coinvolgi- mento collettivo, diffuso in tutta Europa. Voulò pia ‘n bot l’apparequiou, Voulò poué voulà per vè ‘l nebbies d’andin. Tchamà m’entaout fà a ‘n bal courbas, Quial d’ajouc ou m’à dit “è vat lou papè”. “Oh sindic, dai fame ‘n papè, Ma dai fame ‘n papè quë me veou voulà”. “Me lou papè t’lou fou prou Ma ricouardete bin quë è vat ‘na punhà ‘d solt”. “O sgnouri te famen piazi Ma te fame’n piazi dame ‘na punhà ‘d solt”. “Gi steisou isì a ‘d’na ‘d solt a tuti Me a stoura isì srì ja povrou me te”. Voulò pia ‘n bot l’apparequiou, Voulò poué voulà per vè ‘l nebbies d’andin, Ma sensa la mia punhà’d solt Min carou courbas me restou isì sout. Min carou courbas se t’en quouentes la storia, La storia dël nebbies d’andin,
- 6. Me an paga gi ‘t quouentou la quouenta, Gi ‘t quouentou la quouenta d’in bal Blu l’azard. Le nuvole da dentro Volevo prendere una volta l’aeroplano, / volevo provare a volare per vedere le nuvole da dentro. / Ho chiesto come bisognava fare a un bel corvo, / lui da appollaiato mi ha detto: “Ci vuole il permesso”. / “Oh sindaco, dai fammi un permesso / ma dai fammi un permesso che io voglio volare”. / “Io il permesso te lo faccio anche / ma ricordati che ci va una manciata di soldi”. / “Oh signore fammi un piacere / ma fammi un piacere, dammi una manciata di soldi”. / “Rimanessi qui a dare soldi a tutti / io a quest’ora sarei già povero come te”. / Volevo prendere una volta l’aeroplano, / volevo provare a volare per vedere le nuvole da dentro. / Ma senza la mia manciata di soldi / mio caro corvo resto qui sotto. / Mio caro corvo se racconti la storia, / la storia delle nuvole da dentro / io in cambio ti racconto la storia, / ti racconto la storia di un ballo dei Blu l’azard. 6.Lhi sonaires (òc) parole e musica di Dario Anghilante Nuova composizione ma dagli stilemi tradiziona- li, una corrente della Val Varaita che racconta di una festa. Una danza antica che ancora si balla, un racconto scritto ma che ancora si vive. Sus la plaça dal país lhi a la gent qu’arriba, qu’arriba lhi a fins Glaude d’ Filipet bo sa banda de mainaas Oai! que son arribats lhi sonaires, lhi sonaires abo la viola e semiton, abo lo pifre e lo violon Oai! que son arribats lhi sonaires, lhi sonaires abo correntas e rigodins fan balar fins lhi topins Lo sacrista bodeta jaiós la serventa adòba lo preire per la fèsta an trabalhat fins lo messo e Jaco soterraor Oai! Que ………….. Ò! Lo diau d’aquest violon grata, freta coma na rèssea tira e mòla abo l’organet la semelha pituest lordet Oai! Que ………….. Un comença ‘‘na treça en Sòl l’autre pròva ‘‘na marcha en Re brava gent avem minjat tròp o magara es colpa dal vin Oai! Que ………….. La correnta ben s’arreviòuta ental virar eira, eira chal campar-se, vira tu que viro iu Cern balarin la pus jòlia filha lhi sonaires son aicí fins a lo matin Siem la banda mai alegra que se sie vist fasem corre fins lhi sòps e lhi estropiats e lhi sensa flat Cern… Gai gai, pita l’auceleta Pita l’auceleta e puei s’en vai
- 7. I suonatori Sulla piazza del paese / c’è la gente che arriva, che arriva / c’è anche Claudio di Filippo (sopranno- me) / con il suo stuolo di figli. Oh! Sono arrivati i suonatori / con la ghironda e l’organetto, con il flautino e il violino / Oh! sono arrivati i suonatori, con corrente e rigodins (danze) fanno ballare anche gli stupidi. Il sacrestano suona le campane a martello con- tento / la perpetua prepara il prete / per la festa hanno lavorato fin il messo e il becchino […]. Oh! Quel lazzarone di violino / gratta, sfrega come una sega / tira e spingi con l’organetto / sembra piuttosto ubriaco […]. Uno inizia una treccia (danza) in Sol / l’altro prova una marcia in Re / brava gente abbiamo mangiato troppo / o forse è colpa del vino […]. La corrente s’attorciglia nel girare, adesso, adesso bisogna lanciarsi, gira tu che giro io. Scegli ballerino / la più bella ragazza / i suonatori sono qui fino al mattino. Siamo la banda più allegra che si sia mai vista / facciamo correre anche gli zoppi e gli storpi e quelli senza fiato […]. 7.Ouroboros II(fp/it) «Tanti auguri – grazie / uno solo corretto grappa, cosa che mi interessa – chi vuole il caffè? - poi due genepy e io pago, quanto devo? / ha scolato una bottiglia di genepy e buona notte – ora mentre siamo qua possiamo ancora bere una volta – no, no lasciamo solo perdere altrimenti non siamo più a posto, questa mattina abbiamo già bevuto un po’ troppo». 8.Demeisèla (òc) tradizionale. Melodia e testo raccolti a Mens (Isère, Rhône-Alpes) da Julien Tiersot tra il 1895 e il 1900 e pubblicati in: Chansons populaires recueillies dans les Alpes françaises (Savoie et Dauphiné). Al tempo della ricerca questo brano venne documentato come rigodon ma lo stesso Tiersot notava che la medesima aria veniva adat- tata a danze differenti e attestata in numerose regioni francesi. Nel nostro caso si tratta di una bourrée a due tempi. Demeisèla que dançatz, qué tant ne’n fasatz la fière, Demeisèla que dançatz, qué tant vos n’entortilhatz. Ne’n vos entortilhatz pas tant, demeisèla, demeisèla, Ne’n vos entortilhatz pas tant, que soi pas vòstre galant. Signorina Signorina che danzate, che siete tanto orgogliosa ... / quanto vi dimenate. Non dimenatevi tanto ... / che io non sono il vostro galante.
- 8. 9.Maria bela(fp) parole e musica di Flavio Giacchero. Polca ispirata ad una fiaba di magia documen- tata nella Valle di Viù dalla ricerca degli anni Settanta di Donatella Cane e pubblicata in Favole e leggende della Valle di Viù. E’ interessante notare che le “tre masche” (figure femminili legate al mondo magico alpino: fate/streghe) a volte sono chiamate “tre madri” e che a Viù è stato ritrovato un grande masso (oggi esposto presso il parcheg- gio), datato al III-II sec. a. C., sul quale sono rappresentate in bassorilievo tre figure femminili con le braccia rialzate e tra loro unite (danzano?), testimonianza degli arcaici culti legati alla terra e alle “Matrone”. Dietro alla figura delle masche a volte è possibile intravedere frammenti delle culture che ci hanno preceduto e le loro divinità. An bòt a i avet / trai masquë cou / stazoun an pouinta / d’ ina mountanhi granda é scura. Coun ‘na fìi / coun ‘na fìi tan bela / cou li dizoun / Maria, Maria Béla ... Tuiti li bo / cou tournavou a ca / per mountà su lai / lë masquë ou braiavou: Maria Béla / tira ju al touë troessë bélë / tira su ‘l touë / mari, mari vieië ... E Maria / a tapàvë ju / ‘l sou bélë troessë é poi / a tiràve su ‘l trai masquë. An beou jouorn / an prinsi cou / i alàve a chassi ou s’à / trouvà per lài é ou i à dit Speta mòi / can que ‘l masquë ou calou ju / i provou co mòi / ‘d chamà, chamà la béla ... É paroi / ou i à fait / partiië ‘l masquë qui ou sa / butà a braìa Maria Béla / tira ju al touë troessë bélë / tira su ‘l touë / mari, mari vieië ... Maria a i à tapà / ju ‘l troessë / ma a ou post dël masquë / a i à tirà su ‘l prinsi É lou prinsi / stupì ‘d ve ‘na fìi si bela / l’à pourtài / vià, vià coun quiou ... Maria bella Una volta c’erano tre masche che vivevano sulla cima di una montagna grande e scura. Con una ragazza, con una ragazza tanto bella che tutti dicevano Maria bella. Tutte le volte che tornavano a casa per salire lassù le masche gridavano: Maria bella, tira giù le tue trecce belle, tira su le tue madri vecchie. E Maria tirava giù le sue belle trecce e poi tirava su le tre masche. Un bel giorno, un principe che andava a caccia, si è trovato nei dintorni e ha detto: Aspetta un po’ (lett.: spetta me), quando le masche scendono giù provo anch’io a chiamare la bella. E così lui ha fatto, partite le masche lui si è messo a gridare:
- 9. Maria bella, tira giù le tue trecce belle, tira su le tue madri vecchie. Maria ha buttato giù le trecce ma al posto delle masche ha tirato su il principe. E il principe stupito di vedere una ragazza così bella l’ha portata via con lui. 10.Il mondo magico(fp) «A me da piccola mi raccontavano sempre che co- munque c’erano persino le masche che ballavano, e allora c’era la musica, che però non la vedevi e vedevi solo le masche che ballavano, la sentivi solo la musica, i musicanti non li vedevi». 11.L’auriòu qu’a ‘nau plumetas(òc) tradizionale. Un rondeau ma anche una tradi- zionale conta in cui gioco e danza si accomunano nella stessa origine antica. Una versione anche in: Duo Corbefin Marsac, Bal gascon a la votz, 2013 L’auriòu qu’a nau plumetas / nau plumetas l’auriòu (...) Ni non va, ni non vòu / Tan plan vòla vòla vòla / Ni non va, ni non vòu / Tan plan vòla com aquò L’auriòu qu’a ueit plumetas / … sèt / … shieis / … cinc /... quatr /... tres /... dos /... un ... L’ oriolo che ha nove piume L’oriolo (il rigogolo) che ha nove piume, nove piume l’usignolo … Né va via, ne vuole alcunché / Tanto vola bene cosí L’usignolo che ha otto piume … /… sette /… sei /... cinque /... quattro /… tre /... due /... una … 12.Te te rat (fp) parole Pierluigi Ubaudi, musica Flavio Giacchero. Una nuova composizione, su tempo di mazurca, volutamente surreale ed ironica, ispirata al mon- do notturno, alla profondità e alla larghezza della notte nelle nostre valli... una notte che potrebbe essere uscita dal mondo paradossale dei film di Tim Burton e dalla musica di Tom Waits. Tè t’è rat t’a nhin ëlz ales é me quë volou, é me quë volou; Tè t’è rat t’a nhin ëlz ales é me quë volu vou nhin ‘nt ël trappes. Me volou nhin ma rattou al toumes é tè ‘nt la crotta, é tè ‘nt la crotta; Me volou nhin ma rattou al toumes é tè ‘nt la crotta ‘d peu nhin intrà. Tu sei topo Tu sei topo e non hai le ali e io che volo... / non vado nelle trappole. Io non volo ma rosicchio le tome e tu nella canti- na... / non puoi entrare
- 12. 14.Martina ‘d Miziní (fp/it) tradizionale. L’antica tradizione del “cantar Martina”, pratica molto diffusa nelle Valli di Lanzo e Canavese, era legata ai riti calendariali. Inserita nel contesto delle veglie invernali, soprat- tutto nel periodo di carnevale, vedeva alternarsi due gruppi di cantori: uno fuori, a chiedere il permesso di entrare nella stalla della veglia, l’altro all’interno, a rispondere per poi concedere l’ingresso. Delle tante Martine ancora conosciute nelle Valli di Lanzo proponiamo queste strofe, su tempo di valzer, e ringraziamo gli amici di Mezzenile, grandi cantori e suonatori. Bouna seira filere rimboumba la mezzanotte, noi siamo i giovanotti vogliamo la libertà. Chelin che la di fora il cielo è cariato di stelle, viva le bionde belle che trattano il carlevè. An sestou stait Martina chicchipiù chicchipiù toullallena, noi siamo di carnevale chicchipiù chicchipiù toullallà. Soun stait a la fèra madona la stella di là del mare, prega prega la tua mare che ti lasci maridar. Cos t’las coumprà di fèra e la scodella rotonda con due mazzetti in fondo la ricciolina d’amor. A qui vostou regaleilou bernardin bernardin bernardena, a qui vostou regaleilou bernardin bernardin bernardà. A la pi bela dla stala l’uzelin l’è la su la rama, i è la ruza ca lou banha é l’aria lou fa tremar. La Martina di Mezzenile Buona sera filatrici, rimbomba la mezzanotte... / Cariato (= carico) / Dove sei stato Martina... / Sono stato alla fiera, signora... / Cos’hai comprato alla fiera... / A chi vuoi regalarlo... / Alla più bella della stalla l’uccellino sul ramo / La rugiada lo bagna e l’aria lo fa tremare. 15.Mon père a tué un loup(fr) / enceinte sans l’avoir senti tradizionale. Due bourrées a due tempi della regione del Nivernais. Il testo della prima, di cui esistono numerose varianti ed è attestato anche come repertorio di ronde e giochi infantili, è in questo caso ironico e licenzioso. La seconda bour- rée deriva dalla melodia di un canto tradizionale. Una versione anche in: Carré de Deux, À la table des bon enfants, 2012 Mon père a tué un loup, mon père a tué un loup / Avec son grand zighe zighe zighe, avec son grand passe-partout (…)
- 13. Mio padre ha ucciso un lupo Mio padre ha ucciso un lupo... / Con il suo grande zighe zighe zighe, con il suo grande passe-partout. 17.Tiqquele miqquele(fp) tradizionale, musica di Pierluigi Ubaudi Da una filastrocca della Val Grande, riproposta in forma di scottish, un pensiero profondo con un linguaggio poetico e una verità di tutti i tempi, purtroppo: la fame nel mondo. Tiqquele miqquele pam, pam, pam / batend alz ales, ès tan, tan tan. Qui n’à nhin, qui n’à trop / qui n’à tan, tan, tan / Tiqquele miqquele pam, pam, pam. Tiqquele miqquele pam, pam, pam / oh quë fourtuna ‘na mica ad pan. Qui n’à nhin, qui n’à trop / qui n’à tan, tan, tan / Tiqquele miqquele pam, pam, pam. Tiqquele miqquele pam, pam, pam / qui quë lou zgairet, qui quë par la man. Qui n’à nhin, qui n’à trop / qui n’à tan, tan, tan / Tiqquele miqquele pam, pam, pam. Tiqquele miqquele pam, pam, pam / quë an tou lou moundou è aiet pa la fam! Ticchele micchele Tiqquele miqquele pam, pam, pam / battendo le ali e tanto, tanto, tanto / chi non ne ha, chi ne ha troppo, chi ne ha tanto, tanto, tanto / … oh che fortuna una micca (tipica forma di pane) di pane … / chi lo spreca, chi ne ha in mano … / che in tutto il mondo non ci sia la fame! 19.Congòs de Vèrt tradizionale.Suite di due congòs, danza tradizionale della regione storica delle Lande di Guascogna.Una versione anche in: Menestrèrs Gascons, Rondèus e congòs de las Lanas, 1998 20.Crono-logia (it) «Che ore sono? - non lo so / che ore sono!» 21.Ël fasinnë (fp) / courenta tradizionale. Alcune strofette tradizionalmente cantate in Valle di Viù su melodia di corrente. Bozzetti ironici di quotidianità in cui emerge lo spirito ludico delle valli con qualche traccia della cultura magica arcaica. Pian Poumé, località nei pressi di Lemie, è infatti noto come uno dei luoghi in cui ballavano le masche. Segue una corrente tradizionale della Valle di Viù. Ël fasìnnë ‘d l’an pasà, sì ca soun socchi, sì ca soun socchi; ël fasìnnë ‘d l’an pasà, sì ca soun socchi é stajounà. Dili cou venhou, dili cou venhou, dili cou
- 14. venhou a Pian Poumé; Vachë da grìa, vachë da grìa é li chin cou bourou dré. Ohi Maròina quë joi ca fazé, un qui alàvë, un qui alàvë; Ohi Maròina quë joi ca fazé, un qui alàvë é l’àoutou ou viné. Dili cou venhou, dili cou venhou, dili cou venhou a Pian Poumé; Vachë da grìa, vachë da grìa é li chin cou bourou dré. Le fascine Le fascine dell’anno scorso, sì che sono secche... e stagionate. Digli che vengano... a Pian Poumé / vacche da sistemare (pulire e sfamare)... e i cani che corrono abbaiando dietro. Ohi madrina che piacere faceva, uno che anda- va... e l’altro veniva. 22.L’incanto(fp/pi/it) «Viva i priori! - i priori dell’anno venturo! / nero d’Avola, venti, a venti euro il nero d’Avola – venticinque! - a venticinque il vino, a venticinque l’offerta, a venticinque euro! A venticinque e uno, venticinque e due – trenta!- trenta euro – trenta- cinque! - … nero d’Avola!». 23.Jambreina(fp/òc) tradizionale con strofe aggiunte da Blu l’azard Una vera creazione collettiva in cui i quattro ele- menti del gruppo Blu l’azard pronunciano ognuno una strofa nella variante della propria regione. Da un canto tradizionale di mala, riportato solo nella prima strofa, si è immaginato un incontro in osteria, in un ipotetico quanto ingenuo ambiente di mala, in cui si dialoga e ci si racconta. Il primo (fp di Viù) è appena uscito dal carcere dopo diciotto anni (simboleggiato dal sedere di una gallina). Risponde una donna (fp di Giaglione) che lo spedirebbe volentieri in un altro “buco”, quello della Maddalena. Un terzo (fp di Cantoira) ha più a che fare con il piacere del bere che delinquere e il quarto (òc) con il piacere del fumare. L’ultima strofa (in òc) è il saluto e il congedo del gruppo. “Giambreina” stava ad indicare probabilmente le forze dell’ordine nel linguaggio segreto della mala. Valzer. Una versione, con le sole strofe tradizionali, anche in: Ariondassa (in particolare dal repertorio degli amici Vincenzo “Ciacio” Marchelli e Lorenzo “Lampo” Boioli), Il tabernacolo dell’onesto peccato, 2001 (fp) I sè stà dizdoet an ant un cu di ‘na galina É moi i miorrou Jambreina, é moi i miorrou Jambreina I sè stà dizdoet an ant un cu di ‘na galina É moi i miorrou Jambreina, é moi i miorrou par toi.
- 15. Se tsu itaa tant parie te peieus tan itaa An tlou pertui dla Madleina, an tlou pertui dla Madleina Se tsu itaa tant parie te peieus tan itaa An tlou pertui dla Madleina e va aou diaou. Sta nouat ge soueidà lou tirou d’in oubergi Ma coun tout sa ie lasià, ma couentant tout san ge bu an sti an Sta nouat ge soueidà lou tirou d’in oubergi Ma couentant tout san ge bu an sti an, se cou nhin an proufit. (òc) Amont dins lhi bòscs ai trobat n’esclarzada Era tota vèrda, bon Diu que tant d’èrba N’ai fach un baron, ai pilhat la davalada Mas que bèla segada, me siu pròpri argalat. E lo Blu l’azard vos a fach la serada A la chantarèla, a la chantarèla E lo Blu l’azard vos a fach la serada Portatz-nos da beure e al bòt que ven! Jambreina Sono stato diciotto anni in galera (lett.: nel sedere di una gallina), e io muoio Jambreina, …, e io muoio per te. Se sei stato così tanto tempo puoi rimanerne altrettanto nel buco della Maddalena (Val Clarea - Susa), ... e vai al diavolo. Questa notte ho svaligiato la cassa di un’osteria, ma con tutto quello che gli ho già lasciato, ma contando tutto quello che ho bevuto in questi anni, … non sono ancora andato in pari. Lassù nei boschi ho trovato una radura, era tutta verde, buon Dio quanta erba; ne ho fatto un mucchio, sono ridisceso; ma che bel raccolto, me la sono proprio goduta. E i Blu l’azard vi hanno fatto la serata, con il ballo cantato, … portateci da bere e alla prossima volta! 24.Uniti-li-qui-di «Bravi!- è l’ultima, questa qui è l’ultima- ciao, ciao, grazie della compagnia - grazie a voi altri – questa qui è l’ultima eh, l’ultima – andiamo, l’ultima, l’ultima – meglio che andiamo – andia- mo» / (dialogo in mauritano) / «Andiamo – alla prossima – arrivederci e state bene, grazie della compagnia – facciamo l’ultima – ciao e allegri, ci vediamo giù – andiamo va – allegri – ciao - andiamo» / (racconto di magia, frammento). LEGENDA fp = francoprovenzale òc =occitano pi =piemontese it =italiano
- 16. 1. Bella t’è bella / soundscape tale: ouroboros I (trad., Val Grande, Valli di Lanzo, Piemonte e P. Ubaudi / F. Giacchero) 2. Cese bequin (scottish – trad., Gascogne) 3. Gigo (gigo – trad., Valle Varaita, Piemonte) 4. Ël nebbies d’andin (circolo circassiano – parole P. Ubaudi, musica F. Giacchero) 5. Soundscape tale: air and airplane (F. Giacchero) 6. Lhi sonaires (corrente Val Varaita – parole e musica D. Anghilante) 7. Soundscape tale: ouroboros II (F. Giacchero) 8. Demeisèla (bourrée 2 tempi – trad., Mens, Isère, Rhône-Alpes) 9. Maria béla (polca – parole e musica F. Giacchero) 10. Soundscape tale: il mondo magico (F. Giacchero) 11. L’auriòu qu’a ‘nau plumetas (rondeau – trad., Gascogne) 12-Te te rat (mazurca – parole P. Ubaudi, musica F. Giacchero) 13-Soundscape tale: presagili (F. Giacchero) 14-Martina ‘d Miziní (valzer – trad., Mezzenile, Valli di Lanzo, Piemonte) 15-Mon père a tué un loup / en- ceinte sans l’avoir senti (bourrées 2 tempi – trad., Nivernais) 16-Soundscape tale: un taxi un soir (F. Giacchero) 17-Tiqquele miqquele (scottish – trad., Val Grande, Valli di Lanzo, Piemonte; musica P. Ubaudi) 18-Soundscape tale: aubade (F. Giacchero) 19-Congòs de Vèrt (Congòs – trad., Gascogne) 20-Soundscape tale: crono-logia (F. Giacchero) 21-Ël fasinnë / courenta (corrente – trad., Valle di Viù, Valli di Lanzo, Piemonte) 22-Soundscape tale: l’incanto (F. Giacchero) 23-Jambreina (valzer – trad., Piemonte e Blu l’azard) 24-Soundscape tale: uniti-li-qui-di (F. Giacchero) Realizzato con il contributo della L.R. 58/78 Azione a sostegno della diffusione della lingua e della cultura occitana e francoprovenzale